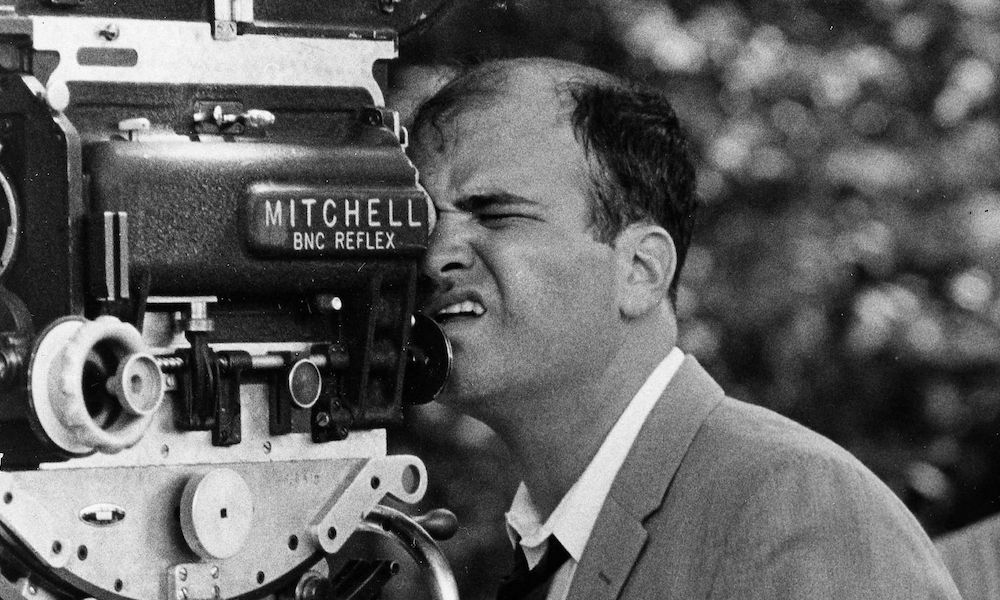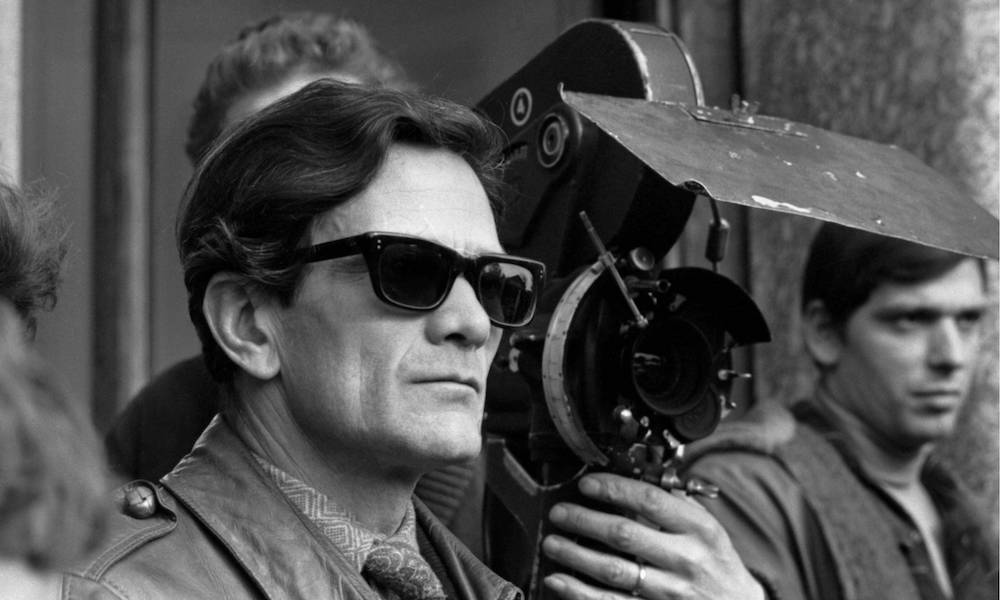Bombetta, baffetti e bastone da passeggio, pantaloni sformati e scarpe consunte, il vagabondo Charlot (The Tramp) emotivo, malinconico e disincantato è l’emblema dell’alienazione umana nell’era del progresso industriale. Charlot è il personaggio attorno al quale Charlie Chaplin, la personalità più influente del cinema muto, ha costruito gran parte delle sue opere. Fellini lo definiva «l’Adamo del cinema», un po’ come se fosse il punto zero, l’origine primordiale della settima arte.
L’attore e regista inglese è stato tra i primi a capire il profondo potere simbolico del grande schermo, le sue idee fatte di immagini e silenzi in realtà gridavano più di qualsiasi altra cosa, così Charlot incarna lo spirito del Novecento, l’uomo schiacciato dal progresso, dalla guerra e dalla miseria, ma comunque testardo e vitale.

Il monello (The Kid) è l’opera prima di Charlie Chaplin, film culto del 1921 con protagonisti lo stesso Chaplin con Jackie Coogan e Edna Purviance. Le riprese della pellicola durano circa diciotto mesi, un periodo che coincide con una serie di infausti eventi che sconvolgono la vita privata di Chaplin: perde il primo figlio poco prima dell’inizio della lavorazione, il suo matrimonio finisce durante le riprese e il film rischia il sequestro. Alcune di queste vicende autobiografiche, sembrano in qualche modo confluire nell’opera, ma in modo lieve e quasi impercettibile, come la regia stessa. Infatti, il regista inglese usa la macchina da presa con discrezione: pochissimi prima piani, riprese frontali a distanza fissa, composizione che valorizza al massimo la recitazione dell’attore che è quasi sempre al centro dell’inquadratura. Dopotutto, Stanley Kubrick stesso sintetizza Il Monello definendolo «niente stile, tutto contenuto».
Il protagonista è un orfano abbandonato dalla madre e trovato per caso da un povero vetraio, che si improvvisa padre e lotta contro tutte le avversità che gli si abbattono addosso, tra toni burlesque e cupi insieme, in una Londra divisa tra ricchi e poveri, il vagabondo e il monello cercheranno di sopravvivere e di restare uniti. Guardando gli occhi pieni di lacrime del piccolo Jackie Coogan strappato dalle braccia di Charlot per essere spedito in orfanotrofio, è sconvolgente rendersi conto che quei fotogrammi hanno quasi novant’anni e che fanno parte dell’immaginario collettivo, uno sguardo puro che si fa cinema senza ricorrere a nient’altro se non all’empatia dello spettatore.

Il monello si caratterizza già come un insieme di quelli che saranno i temi portanti del cinema chapliniano: la denuncia sociale, l’attenzione al mondo degli svantaggiati, la fusione tra comico e melodramma, la cura dell’altro e la speranza. In Il monello, Chaplin adotta un approccio emotivo, ed è qui che ha origine questa commistione tra risata e dolore che caratterizza tutta la produzione di Chaplin, così il suo slapstick irriverente si fonde al sentimentalismo. Furono in molti a criticare questa scelta stilistica, ma il successo del film è indubbio, nonostante il delicato equilibrio che rende la pellicola uno strano ibrido tra un melodramma sentimentale e un film comico.
Alla fine, è semplicemente la storia di un bambino che sperimenta la paura dell’abbandono e il bisogno di sentirmi amato e al sicuro e non esiste niente di più universale e intimo insieme. Chaplin mette in risalto una maternità sofferta e raramente rappresentata sul grande schermo e un legame famigliare non tradizionale, anzi, un nucleo totalmente improvvisato ma non per questo meno vero. «A picture with a smile and, perhaps, a tear», questa è la frase storica che apre Il monello e che sinterizza e racchiude, forse, l’intera filmografia di Charlie Chaplin.