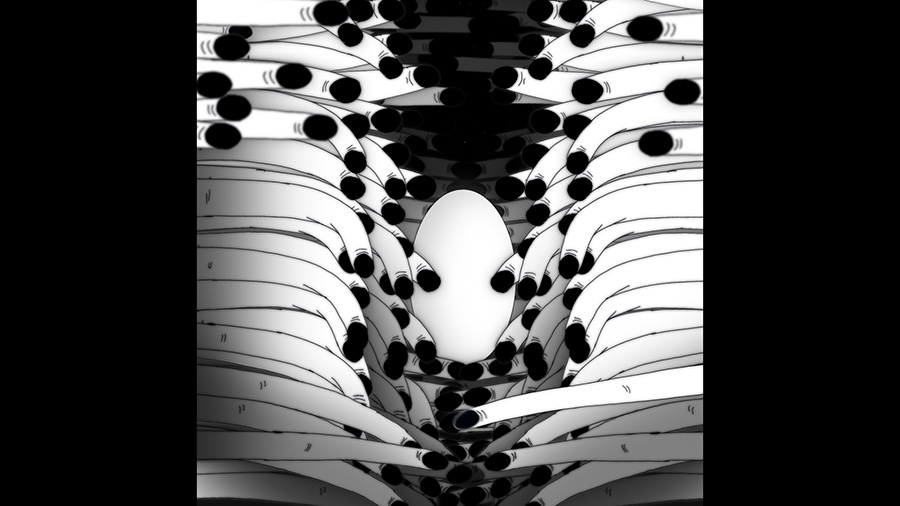Le piattaforme OTT (Over The Top) permettono agli spettatori di vedere quello che vogliono, dove vogliono e quando vogliono. E mentre il mercato del video on demand si fa sempre più affollato, la sfida al vertice resta quella tra Netflix e Amazon Prime Video. C’è un concetto economico che spiega agevolmente il successo di queste due piattaforme di streaming sul mercato globale: quello di Long Tail. Il termine Coda Lunga è stato impiegato per la prima volta nel 2004 da Chris Anderson, saggista statunitense e giornalista dell’Economist.
Per spiegare questo concetto è necessario rifarsi al contesto storico. In un periodo caratterizzato dall’economia dell’abbondanza e dalla rivoluzione digitale, come quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, la legge economica è quella che potremmo definire della “taglia unica”: ovvero, le strategie di marketing puntano a individuare dei prodotti capaci di adattarsi alle esigenze di un’ampia fetta di mercato. Oggi però sono in crescita alternative che cercano di guadagnare spazio: la teoria della Long Tail spiega proprio come l’attenzione dei consumatori sia cambiata, finendo per spostarsi lentamente dalle hit ai prodotti di nicchia. Se le hit all’interno di un grafico sulle vendite sono la testa (un picco) e le nicchie la coda (lente ma costanti), noteremo come quest’ultima tenda all’infinito, producendo una grande quantità di vendite ma spalmate nel tempo.
Sia Amazon che Netflix sono riuscite a trasferire nei propri piani marketing questo diverso concetto economico, applicandolo alla vendita degli abbonamenti. Come afferma Anderson, siamo passati da un mercato di massa a una massa di mercati: se l’economia classica si fondava sulla scarsità, nella nostra epoca caratterizzata dall’abbondanza i prodotti di massa sono destinati a essere sorpassati da quelli di nicchia e le nicchie, sommate fra loro, superano i numeri del mainstream. Questo elemento, secondo la teoria economica del giornalista statunitense, potrebbe portare Amazon Video a battere sulla lunga distanza Netflix, che per ora regna incontrastato.
In Italia, stando ai dati Auditel raccolti durante il lockdown, nel corso dell’anno il numero di visualizzazioni dei contenuti proposti dalle piattaforme streaming è raddoppiato. E, secondo i dati rilasciati dal sito di monitoraggio flussi Reelgood, durante il terzo trimestre del 2020 Netflix ha raggiunto il 25% dei flussi rispetto al 21% ottenuto da Prime Video. L’analisi di Sensemakers con i dati Auditel e Audience Analytics di Comscore confermano la crescita sia di Netflix che di Amazon Video. Entrambi i player però si dichiarano disinteressati ai volumi di traffico – il corrispettivo degli ascolti televisivi – mentre puntano ad aumentare il numero di abbonati e quindi a far parlare di sé il più possibile, per rafforzare la propria brand identity.

Le strategie impiegate dai due player sono però molto diverse: Netflix sa cosa il pubblico desidera grazie al suo algoritmo rivoluzionario, punta sulla quantità e l’hype creato attraverso i social e attua una politica di espansione geografica per raggiungere l’ampiezza di mercato di Amazon. La piattaforma di Jeff Bezos invece segue una strategia completamente diversa, entra di traverso nel mercato video e ha come obiettivo il mantenere la retention, cioè assicurarsi che il cliente resti all’interno del proprio universo: per questo punta su titoli recenti ed esclusivi in aggiunta a tutta un’altra serie di servizi inclusi nell’abbonamento, trascurando un po’ il piano comunicativo. Amazon vuole produrre meno e meglio della concorrenza, coinvolgendo i grandi paesi europei, come ha dichiarato Georgia Brown (direttrice delle produzioni originali di Amazon per l’Europa) a Screen International, laddove Netflix punta a dei contenti sì locali ma con un appeal internazionale.
Diverso è anche l’approccio ai social: mentre Netflix usa una strategia pervasiva ma dal tone of voice divertente e informale, Amazon applica un approccio mirato e discreto. Se i dati dell’audience del colosso californiano sono blindatissimi, non accade la stessa cosa per i suoi profili social che, proprio tramite il tasso di engagement e il numero di interazioni, mostrano in modo trasparente il livello di coinvolgimento del pubblico. In questo modo, Netflix incoraggia attraverso i social la produzione di una grande quantità di contenuti generati dagli utenti stessi, i cosiddetti User Generated Content (UGC), spingendo gli utenti a un dialogo continuo con i profili ufficiali dell’azienda. La strategia social di Netflix differisce quindi per la capacità di rendersi virale, creando un tasso di engagement altissimo. Amazon Prime Video è in ascesa, ma continua ad avere problemi a raggiungere i numeri della piattaforma rivale anche perché la sua social strategy rimane vaga, rendendo meno riconoscibile la sua identità. Prime Video così si riduce a essere un vantaggio aggiuntivo all’interno di un ecosistema più ampio di servizi, un’appendice periferica, nonostante la qualità dei contenuti sia molto più alta della media.
Secondo gli analisti, Prime Video potrebbe riguadagnare terreno con relativa facilità scommettendo su show di punta dall’appeal globale e trasformandosi in un servizio distinto dall’abbonamento Prime: acquisterebbe in autonomia e riconoscibilità, a patto di continuare a investire nei media digitali. Infatti, nel corso del 2019, Amazon ha quadruplicato la spesa per i media, superando come principale inserzionista di servizi streaming Netflix che invece, come Hulu, si è ritrovato a tagliare oltre il 40% degli investimenti, secondo quanto segnalato nella ricerca MediaRadar di MarketingDive.
Non è un caso che l’aumento della spesa media di Amazon per promuovere i servizi video arrivi proprio mentre il mercato dei servizi OTT diventa sempre più affollato e competitivo, rendendo la ricerca dell’attenzione dello spettatore ancora più urgente che in passato. Ad aumentare gli investimenti non sono solo Amazon, Apple e Disney ma le stesse società di social media come Facebook: tutti stanno investendo nella programmazione originale allo scopo di mantenere gli utenti coinvolti nelle app mobili il più a lungo possibile, intenti a produrre contenuti e a generare intrattenimento come accade su Instagram tramite IGTV e Instagram Stories.
Puntare però sulle strategie di marketing più che sui contenuti finirà per creare un’assuefazione nello spettatore, che sarà spinto a ricercare una più alta qualità nelle nicchie – nella coda lunga dell’economia – proprio come sostiene Anderson. Se in questa guerra dello streaming Netflix si rivelasse la testa e Prime Video la coda, allora il futuro delle piattaforme OTT potrebbe ancora sorprenderci.