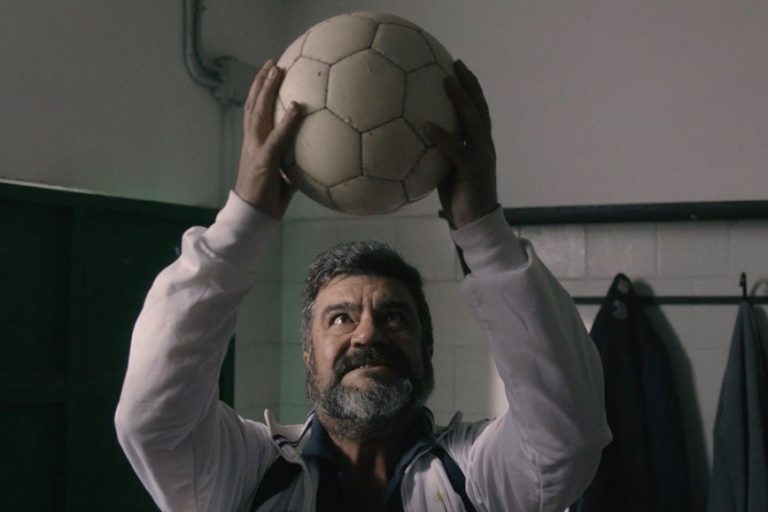All’interno della selezione ufficiale della XIX edizione Alice nella Città trova posto anche l’ultimo film di Tommy Weber, Come prima, in sceneggiatura al fianco di Filippo Bologna e Luca Renucci. Un road movie che lega la Francia a Procida, una storia di due fratelli costretti a ritrovarsi dopo essersi separati 17 anni prima, ai tempi della Seconda guerra mondiale. Fabio (Francesco Di Leva) è una camicia nera mai pentita, rimasto aggressivo e violento nel corso del tempo, mentre André (Antonio Folletto) accantona l’orgoglio per tornare ad abbracciare il sangue del suo sangue in occasione del funerale del padre, scomparso da pochissimo e il cui ultimo desiderio è far riunire i propri figli. Abbiamo discusso del film con il regista e Antonio Folletto in occasione di un incontro ravvicinato.
Come prima è tratto dall’omonimo graphic novel dell’artista francese Alfred. Cosa ti ha affascinato e come è nata poi l’idea di farne un film?
Tommy Weber: Cercavo da diverso tempo di scrivere una mia sceneggiatura che parlasse di due fratelli. Quando poi mi è capitato di leggere il lavoro di Alfred mi è sembrato che fosse tutto già pronto per essere portato sul grande schermo. L’ho amato tanto e da subito, raccontava tutto in maniera molto diretta, piena di luce e umanità.
Antonio Folletto: Io il graphic novel l’avevo già letto in tempi non sospetti. Un anno e mezzo prima del film il nostro produttore, Luciano Stella, mi dice di leggere assolutamente il lavoro di Alfred perché era convinto che avrebbe trovato il modo di portarlo al cinema. Siccome lui è una persona seria che se dice una cosa poi la fa, poi è andata effettivamente così. Tommy ci ha aiutato molto per l’impianto della storia, ma non ci siamo mai posti il problema di essere esattamente aderenti a quello che c’è nel lavoro originale. L’importante è la dinamica tra i due fratelli, del loro amore e del viaggio che li porta a Procida.
Il film è sostanzialmente un road movie, un viaggio di formazione e di riscoperta della relazione tra i fratelli. Come avete gestito il passaggio dai momenti più tesi a quelli di rilascio, a volte quasi comici?
TW: Abbiamo lavorato a quattro o cinque letture del copione prima di lavorare in scena. È stata una cosa molto importante per me perché non parlo l’italiano molto bene e ai tempi delle riprese lo parlavo anche peggio. La comunicazione con gli attori era la mia più grande paura. Ho avuto un’assistente che mi ha aiutato moltissimo, Lucia Ceracchi, così da avere un dialogo con Antonio e Francesco con i quali abbiamo parlato molto tranquillamente di come io sentivo i momenti di violenza e di tormento. Sono una persona molto impulsiva e mi piace quando l’emozione emerge ed esce fuori. L’ho detto agli attori e Antonio e Francesco hanno avuto fiducia di me come io l’ho avuta della loro idea di personaggio. Ho avuto la fortuna di lavorare con due attori come loro, che si sono “tuffati” e hanno abbracciato i momenti di violenza come quelli di tenerezza.
AF: In questo senso ti aiuta molto la stanchezza… Come accade nella vita di tutti i giorni, dove quando discuti a lungo con una persona le cose alla fine diventano naturali, perché sei stremato e non ce la fai più. Quei momenti arrivavano così, ci aiutavano perché andavano a smussare lo scontro perenne tra i due personaggi.

La scelta dei luoghi e delle location in un film in movimento come questo è importante. Come avete lavorato da questo punto di vista?
TW: La verità è che non abbiamo avuto tanta scelta perché dovevamo girare una gran parte del film entro cinque settimane. Abbiamo girato molto ad Arpino, un luogo ricco di paesaggi e differenti scorci.
I personaggi di André e Fabio sono in contrapposizione tutto il tempo. L’unica cosa che hanno in comune sono il padre e una donna che forse amano entrambi. Come emerge nel carattere dei personaggi?
AF: Il padre è usato da André come pretesto per portare Fabio a casa. Non che non gliene importi realmente, è una cosa che fa soprattutto per se stesso. Va a prendersi suo fratello perché ne ha bisogno. Fabio è tremendamente aggressivo, ma anche André dentro di sé lo è e in alcuni momenti lo vediamo anche da fuori: è come un grido di aiuto nei confronti del fratello più grande che se ne è andato. C’è una frase bellissima che Tommy ha scritto assieme agli sceneggiatori, quando André dice a Fabio «la verità è che Maria stava con me per stare un po’ con te, e per me era lo stesso». Entrambi cercano colmare un vuoto: uno fuggendo lontano da casa, senza più nulla in mano se non i traumi del passato. L’altro facendo lo stesso viaggio, per poter sciogliere tutti i dubbi rivedendo il proprio fratello.
A guardare alcuni eventi recenti accaduti qui in Italia sembra che ci siano dei conti in sospeso con un passato mai realmente affrontato, come quello del fascismo che fa da sfondo anche alla storia di Come prima. Quanto ritieni sia importante approcciare questo genere di discorsi al cinema?
TW: La cosa che per me era più importante era il parlare di uomini, soprattutto quelli come Fabio, che era un fascista e continua a rivendicarlo. Di fatto è uno stronzo, violento e dai tanti aspetti negativi. Per questo penso sia importantissimo portare uno sguardo di amore e umanità su questo tipo di persone: sono persone che dimentichiamo spesso, perché è più facile lasciarle perdere, perché sono difficili da comprendere, ma nei confronti delle quali dobbiamo cercare comunque un dialogo.