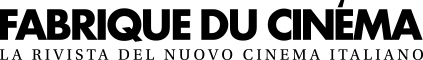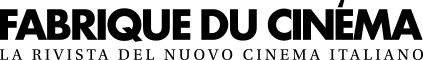Ha presentato il primo corto Notte romana a Venezia nel 2021 e, quest’anno, ha vinto La Cinef di Cannes con Il barbiere complottista, ora in première italiana ad Alice nella Città. Appena diplomato dal Centro Sperimentale di Cinematografia, Valerio Ferrara è già una promessa. L’abbiamo incontrato per parlare di futuro ma, soprattutto, di presente.
Valerio, classe ’96, ha un sorriso ampio e accompagna la conversazione via zoom a grandi gesti: è pieno di quell’energia, che, dalla partecipazione di Notte romana alla Settimana Internazionale della Critica (SIC) della 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, l’ha portato alla vittoria nella sezione Jeune Cinéma/La Cinef del festival di Cannes, ribalta dei migliori corti provenienti dalle scuole di cinema di tutto il mondo. È il suo lavoro di diploma del Centro Sperimentale di Cinematografia, Il barbiere complottista, a trionfare davanti ai colleghi di Cina e Ucraina. La motivazione della giuria, unanime: non c’è strada migliore per raccontare le minacce al nostro presente, le insidie del futuro, che mettere in primo piano il complottismo e le sue conseguenze ormai inestricabili dai pensieri di tutti i giorni. Anche se il racconto del fenomeno giunge ben calato e radicato in una Roma comune, di quartiere, contemporanea, dove chiunque potrebbe, tra un colpo di rasoio e l’altro, ricevere succosi scoop sui rettiliani da parte del proprio barbiere di fiducia. Anche – anzi, soprattutto – visto che Il barbiere complottista è una commedia, l’unica inserita nella rosa della selezione.
«Che poi certo, parlando di generi, Il barbiere è di sicuro una commedia, ma una commedia che non si ferma al sorriso di superficie. A Lucio (Patané, interprete del protagonista Antonio Calabrò) continuavo a ripeterlo: non deve far ridere. Piuttosto, deve essere assurdo». E l’assurdo, ne Il barbiere complottista, arriva subito, molto vicino. Si comincia dall’ossessione di Antonio per il lampeggiare dei lampioni della città, codice morse alieno; dal campo-controcampo tra Patané e il PC su cui il barbiere compila ossessivamente, interlocuzione allucinata, il suo blog complottista. Si continua con un raid della Digos a casa di Antonio: gli devono confiscare il computer, deve seguirli in centrale, è proprio lui il signor Calabrò? La legittimazione, per il barbiere, non è mai stata così dolce, così agognata: i dati raccolti sono allora importanti, possono davvero imbarazzare nomi potenti ai ranghi alti del complotto, e invece no, tutto si scioglie nello svelamento di un attacco hacker, pericolo ben più reale di Bill Gates e microchip. E i lampioni? Be’, risponde il comandante di centrale, è semplice, il Comune non ha i soldi per tenerli sempre accesi e deve interrompere la corrente. Ma è al ritorno a casa del battuto Antonio che la commedia rivela tutta la sua forza tragica: l’arresto ha dato una motivazione ad amici e famigliari per credere, infine, alle teorie del barbiere, e lui non si è mai sentito così forte.

«Vedi, secondo me bisognerebbe tornare a prendere la commedia sul serio, non come quella cosa che usi per spegnere il cervello e fare soldi al botteghino. Il cinema italiano ha una tradizione senza paragoni nella commedia, ma oggi, se guardo i film fatti per far ridere, parecchi sono vuoti, senza una direzione, non vanno oltre la battuta. Chissà in che guaio mi sto cacciando a dirlo, ma, per me, ridare corpo e sfaccettatura alla commedia è una questione di responsabilità». Gli chiedo di più. «Monicelli, Risi, De Sica, Comencini, i maestri della nostra commedia avevano capito come fare una cosa, ovvero lasciar parlare la realtà. Prendi Il vedovo (1959) di Dino Risi. Ecco, Il vedovo altro non è che un fatto di cronaca, il film si ispira al caso Fenaroli. Quindi la mia responsabilità girando e scrivendo Il barbiere è stata documentarmi scrupolosamente su tutto quello che mettevo sullo schermo, dando forma sia alla vena comica che a quella seria. Quando arriva la Digos, per esempio, dovevo sapere come effettivamente la Digos avrebbe potuto presentarsi a casa di un sospettato, quindi sono andato in centrale a indagare. Se Antonio fosse stato solo ammanettato e portato via, avrei tradito la realtà, e non volevo espedienti facili, di ilarità facile. Lo stesso per tante altre dinamiche sia de Il barbiere che di Notte romana».
Per Valerio, il tempo, storico e no, è una cosa seria, lo si nota dalla qualità dei suoi lavori. «Mi piace l’idea che le persone si siedano in sala e abbiano la possibilità di entrare gradualmente nello spirito del film. Poi c’è anche una motivazione più triviale, perché io al cinema sono sempre arrivato in ritardo e puntualmente mi perdo l’informazione fondamentale nei primi due minuti. Così ho deciso che non metterò mai le informazioni fondamentali nei primi uno o due minuti di film».
Anticipazioni? «Ancora non c’è nulla sul piatto, ma posso dire che mi sono innamorato del complottismo, e voglio capirlo ancora più a fondo. Credo che, per il momento, proverò a lavorare su quello. Probabilmente con un lungometraggio». Niente panico, quindi, se vedremo Valerio inquadrato in qualche raduno di terrapiattisti sul TG nazionale. «Per preparare Il barbiere sono stato a vari raduni, ho letto e imparato molto sul tema. Credo di aver capito che esistono vari livelli di complottismo: vanno da quelli che non farebbero male a una mosca a quelli che sarebbero pronti ad aprire il fuoco. C’è poi un’altra cosa che mi spaventa e quindi mi interessa del complottismo: oggi, a mio avviso, è l’unica ideologia che ancora resiste nel mondo occidentalizzato. Se c’è qualcuno che sta costruendo mondi paralleli, questi non sono sicuramente i registi o gli scrittori, ma i complottisti. Poi mai dire mai, magari la prossima volta che ci vedremo avrò fondato la mia personale ideologia complottista a favore della rinascita della commedia italiana. Magari c’entreranno le luci dei lampioni».
L’ARTICOLO COMPLETO È DISPONIBILE SOLO PER GLI ABBONATI, CLICCA QUI PER ABBONARTI A FABRIQUE